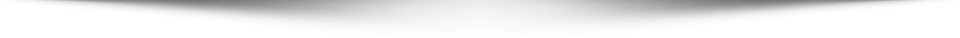Quella curata quest’anno da Christine Macel è una Biennale, la 57esima, “sperimentale”, nel senso che è un esperimento a cielo aperto, un’arte visiva e contemporanea e che, in quanto tale, può piacere come non piacere. Seppur particolare nel suo insieme, a noi di Led è comunque piaciuta.
Ci siamo soffermati sulle opere che ci sono piaciute di più, non avendo avuto tempo di osservarle tutte. Ancora una volta è stato il Bel Paese, e la terra Veneta nello specifico, a fare la sua parte nell’entusiasmante gioco della cultura, e lo ha fatto mettendo a disposizione padiglioni e spazi a cielo aperto. Noi abbiamo visto per Led i Giardini e l’Arsenale, il secondo la continuazione dei primi.
Arrivata addirittura per le strade della città (ricordiamo, a tal proposito, la già citata “mano” di Lorenzo Quinn e il “King Kong Rhino” di Shih Li-Jen, conservato presso i Giardini Marinaressa), la Biennale ci ha entusiasmato per quello che di più concreto ha potuto offrirci: Venezia, la Serenissima nei suoi canali e ponti più sinceri.

Temi portanti dei padiglioni da noi visionati, e del Centrale prima di tutti, sono il Libro e l’Immagine; in altre parole, come, nell’attualità dei nostri giorni, il Libro abbia perso il suo originale significato educativo per abbracciare quello invece puramente estetico. Ciò equivale a dire che si scrivono ormai libri non tanto per leggerli, quanto più per averli con sé e guardarli senza farci niente. Il Libro, e questo è quello che ci ha insegnato questa Biennale, è un po’ come un oggetto da collezionismo: tutti lo vogliono per il semplice gusto di averlo. Quella del tramonto della scrittura è dunque la lezione, se così la si può definire, che ci arriva dai libri privi di parole degli artisti giapponesi; quello in figura ne è un esempio: libri in quanto tali, esposti uno affianco all’altro e aperti a pagine a caso e prive di parole. Quello che un tempo era il linguaggio, la necessità di leggere, cede ora spazio al semplice gusto estetico di vedere un libro e di averlo tra le proprie mani. Libri vuoti, senza più alcuna parola: ciò che hanno perso i libri arriva a confluire nella memoria collettiva. È una memoria, questa, rappresentata dai molti quadri che la storia ha visto nascere: autori neppure minimamente sentiti come affini vedono le proprie opere intrecciarsi in un intrigante reticolo di schizzi, progetti e tratti di matita, dando così vita a un’opera d’arte che ne racchiude molte altre. Questa è la necessità di fissare su carta la memoria collettiva, una memoria forse minacciata dall’avvento di una tecnologia che ne mina le basi.

Stessa necessità di creare una memoria organica, un qualcosa cui fissare la biografia degli uomini la si ritrova in un’opera che, a prima vista, potrebbe apparire come un indistinto aggregato di tanti piccoli quadrati. L’occhio percepisce appena un quadro disarmonico, quadro che diventa, però, coerente e nitido solo se lo si guarda da vicino: gli infiniti, piccolissimi quadrati che costituiscono la tela contengono, infatti, annotazioni, numeri, nomi, dati biografici di chissà quante persone. L’autore fissa dunque una memoria collettiva sulla tela, affidando, in tal modo all’arte, l’onere e l’onore di custodire il bene più prezioso che ci sia: la biografia dell’uomo. Indirizzi telefonici, luoghi, nomi, abbreviazioni: l’arte è custode di tutte quelle informazioni basilari che fanno degli uomini gli uomini veri e propri.
Immagine, quella dell’essere umano, che si pone a conclusione della nostra analisi: in una congeniale tela rettangolare, giochi di bianco e nero affliggono un uomo prima impaurito, poi ansioso, soltanto infine sofferente. Stavolta il linguaggio passa alla fotografia: l’autore vede la fotografia come linguaggio affine ed aderente alla realtà, superando, così, una pittura a mano forse troppo scontata o lontana per dell’arte contemporanea.
Se prima l’uomo si sbraccia su uno sfondo bianco simbolo di sicurezza, dimostrando, in tal senso, di sentirsi a proprio agio, si rannicchia, infine, su se stesso quando il bianco lascia spazio ad un nero opprimente, simbolo dell’incertezza umana e, così, della sua corruzione. Il nero ne attacca i sentimenti come il corpo: il torace e le gambe sono brutalmente attaccati da sprazzi di nero, lasciando al soggetto la soluzione di torturarsi nel suo animo.
Questa è la Biennale, questo il bisogno primario di fare dell’arte un veicolo superiore di idee, idee che travalichino i confini dell’uomo, instaurando, in tal senso, un sentire comune del cittadino di mondo.
Francesco Zaralli